Il suono della lingua e il suono delle cose. Anzi, il suono della voce. È così che titolerei un saggio sulla poesia di Mario Fresa se mi fosse concesso di scriverlo. Mi spiego: Fresa ha il dono di conoscere entrambe le modalità in cui la voce umana tende ad autorappresentarsi: in forma impostata e intonata, cioè in quella speciale rivelazione fittiva che è il canto lirico, e la forma scritta, la cui struttura originaria si dà a noi, da millenni, come testo poetico. La sola differenza è che mentre quando si imposta la voce è necessario estroflettersi e mandarla fuori (Mario Fresa è un baritono e lo sa bene), in poesia il linguaggio bisogna andarlo a recuperare attraverso uno scavo che può essere senza fondo, senza appigli, persino senza scopo. C’è solo la felicità di dire, e nessun altro premio da vincere. La poesia, fondamentalmente, è questa felicità gratuita e imprevedibile.
È così anche nel nuovo libro di Mario, Bestia divina, col quale il poeta salernitano compie un ulteriore balzo in avanti rispetto a Svenimenti a distanza, il suo lavoro precedente, ovvero tocca il punto più basso e misterioso del linguaggio, con una costanza di risultati e una semplicità davvero invidiabili. Tutto parte da una concatenazione di eventi, che vengono taciuti. A parlare sono dei personaggi che più che esseri umani sono ipotesi semantiche, in lotta tra loro e sempre minacciati dal rumore, ossia dal caos, dal non senso, dalla morte, che è nuovamente silenzio.
L’inarticolazione verbale è scacco all’esistenza. Kurt, Antonio o il Manicheo, se non riescono a trovare il modo di parlare, non rinunciano soltanto a fare poesia. Semplicemente muoiono, escono dalla spirale del linguaggio. Ed è quello che sembra accadere a tutti i personaggi “parlanti” di questo libro, ovvero di questa saga. La voce di uno inizia dove finisce quella del precedente, e chi muore non lascia eredità di affetti ma solo affinità di lingua. Lingua che procede raso terra ma sa alzarsi a vette considerevoli (si legga, per esempio, Lupo-bambina). Lingua che reinventa se stessa nel suo divenire autoriflessivo di Soluzioni, lingua che sa di essere un fragile trampolino che rivela l’inconsistenza e la precarietà della vita, mettendo in scena scenari quasi beckettiani che si sospendono “in punta di lingua” (appunto) tra il tragico e il grottesco. E forse, e dico forse, quest’ultima oscillazione è il filo d’Arianna che attraversa tutto il libro, e che permette al lettore di non smarrirsi nei labirinti verbali che Fresa costruisce con sempiterna maestria. Perché più che l’assenza del sentimento, comune a tanta poesia contemporanea, si propone qui un gioco di specchi, un invito a smarrirsi, a essere, come poesia, la Bella di nessuno (come titola uno dei testi più tipici del libro), ossia una voce di tale purezza che non si ha chi la pronunci.
Eppure, come atto, la lingua si dà, è qualcosa, viene udita e resta visibile sulla pagina stampata. Non è mai la nostalgia di un’eco (Fresa volutamente non tocca mai questa corda). Non a caso Andrea Corona, nella sua eloquente prefazione, chiama in causa Heidegger e Lyotard. Ma non ci si illuda di chiudere la modernità terminale di questa poetica nell’angusto recinto del post-moderno. Quest’ultimo presuppone una assenza di pathos e una memoria che nel farsi citazionista produce a suo modo (e con cattiva coscienza) una visione del mondo patinata e volutamente finta. Niente di tutto questo in Bestia divina, dove il soggetto scompare dietro la frase, la disturba e la sconnette con concrezioni e combinazioni atipiche come «madre orologio» o in locuzioni enigmatiche come «Il cameriere annuncia / l’orologio e tanta carestia». E questo è certo, questa poesia che si fa specchio linguistico di un mondo totalmente evaporato nelle sue discriminanti logiche, morali, economiche e religiose, è rigorosamente il frutto della sua epoca, del tempo storico in cui è scritta. Il tempo di una carestia dell’umano che solo un materiale linguistico estremo può disvelare in tutta la sua depauperata tragicità.
Eppure Fresa non è nuovo a questo sapiente utilizzo della lingua come scandaglio e calco apocalittico di ciò che manca o è venuto meno. Ma in Bestia divina questa mancanza ontologica, che, come una fessura nella roccia, riproduce voci umane impressionanti, la mancanza necessitata, è parte stessa dell’assunto poetico, si fa attore (o attrice) insieme ai parlanti, ai fondali, al ridicolo, al falsetto rococò delle situazioni poste in essere e create dalla lingua, per solo peccato di lingua. In pratica, Fresa, in questo lavoro, prende per la prima volta in considerazione l’opzione del silenzio, del silenzio provvisorio o definitivo che si oppone all’esplosione poetica.
In questo libro, la suspense consiste proprio in questo: i testimoni, i parlanti, la voce poetica stessa non è più data per scontata solo perché abbiamo aperto un libro di poesia. La voce può venire a mancare. Il parlante, quindi, può scomparire, il tempo della narrazione poetica annullarsi. Per fortuna questo non accade, o almeno non ancora. I reperti “asmatici” (ricordate l’asma-vita zanzottiana?) di Fresa, nel suo coronamento linguistico, lo stanno a dimostrare. Anche se, come scrive in Colpo di dadi (e come non pensare a Mallarmé – ma qui a pronunciare è una donna, che «sviene al millesimo»), si «morirebbe in pace, per molto meno». Lo faremmo tutti se potessimo, viene da dire, a meno che la forza vitale erompente in linguaggio poetico o comunicativo, non comporti una alternativa, anzi, ci faccia contemplare l’infinito come possibilità che la lingua ci offre, in un mutevole stato di afflizione e di conforto, come estrema resistenza del vivente e del poetico, dopo che lo scacco è stato già metabolizzato e si trova a priori di questo intenso lavoro letterario
Non perdere i nostri aggiornamenti
Elaboreremo i dati personali forniti in conformità con la nostra politica sulla privacy.
Articoli Recenti
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO o la consistenza dell'individualità di Francesca Sallusti Questa opera ha il suo principio
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE di Francesca Sallusti Apre la mostra una sala dedicata a pittori coevi a Van gogh, come Renoir
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI Testo poetico di Francesca Sallusti sull'opera di Gianmaria De Luca DA "MAAM - MUSEO DELL'ALTRO E DELL'ALTROVE" di Gianmaria De Luca
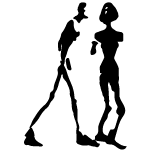


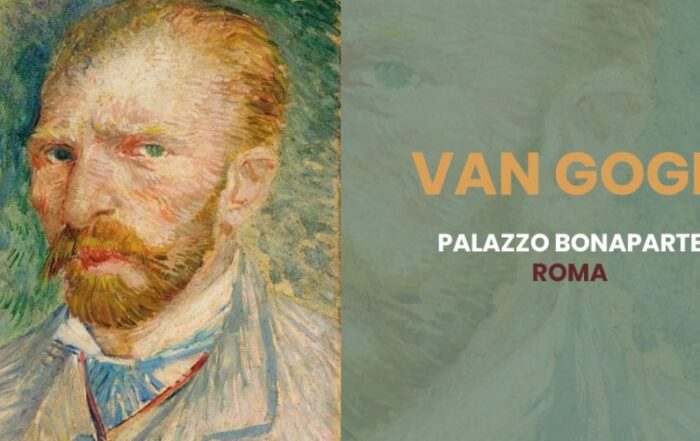

[…] Il suono della lingua e il suono delle cose (Civiltà Magazin – 23 agosto 2020) […]
[…] Il suono della lingua e il suono delle cose (Civiltà Magazin – 23 agosto 2020) […]