Un breve tour per le città d’Olanda, tra Amsterdam e Delft, per strade e per musei, in compagnia della mamma e del papà. Di questo è cronaca Amsterdam, pubblicato dal poeta Jacopo Ricciardi con marchio ‘PlayOn’ su www.ilmiolibro.it nel 2008. Figuratevi quale, tra i nostri romanzieri e poeti quarantenni, sceglierebbe per sé un simile argomento. Se non per farne un noir, un horror, un grotesque. Ricciardi invece sviluppa da questo nucleo tematico un inno alla vita e all’arte, e una elegia del rapporto filiale.
Il libro è scandito in brevi paragrafi compatti, in cui si confondono – quasi correnti nei canali d’Olanda – tre temi: la riflessione sulle opere d’arte, una elegia commossa della relazione tra il figlio, la madre e il padre, e una meditazione sull’esistenza, sull’uomo, sul mondo.
Lo stile e la lingua sono semplici, essenziali, composti. Si passa con naturalezza dalla descrizione al discorso diretto, alla interlocuzione, dal monologo interiore al dialogo in absentiam. Tradiscono a tratti la frequentazione dei grandi autori giapponesi, come Kawabata Yasunari e Kenzaburo Oe (e.g., “Il cuore umano emana per un secondo un riflesso bianco, come sul corpo guizzante del pesce nell’acqua bassa.”). Anche il tono delle meditazioni ha una eco d’estremo oriente, nell’accettazione acritica di una “concezione naturale” dei termini fondamentali del discorso: “uomo”, “mondo”, “vita”, “tempo”, “spazio”. Ma il libro – per quanto inedito nella scelta dell’argomento e nel suo trattamento – è tutto occidentale, ha come obiettivo “la bellezza che abita nel tempo, come solo noi occidentali sappiamo fare”.
Dell’esperienza di Ricciardi come poeta sperimentale risente la costruzione temporale del romanzo. Laddove da principio i paragrafi sembrano tracciare la linea di una narrazione continua, quasi un carnet de voyage di un turista à rebours (dall’Italia verso Nord: “Certo, non sono stato in Islanda, nelle isole Faroe, nelle Svalbard, tra i ghiacci della Groenlandia”), presto la continuità è perduta, tanto nella successione dei paragrafi quanto all’interno dei paragrafi stessi. Non solo gli episodi del grand tour non sono narrati nell’ordine in cui accadono, ma è la percezione stessa che l’io narrante ha del divenire temporale e dell’ordine dei propri movimenti nello spazio a divenire presto flou, incerta, infine essenzialmente indeterminata. L’io narrante non ricorda o non sa se stia parlando di un quadro che ha già visto o che vedrà domani. Non sa se si stia rivolgendo a suo padre o a sua madre (“se adesso sto parlando con te mamma, o con te papà, è così difficile distinguere, ora, con chi dei due lo stia facendo.”). Non sa se stia parlando direttamente a loro, o se stia parlando loro in loro assenza. Il tempo del romanzo si fa liquido come le acque nere dei canali che fondano le città di Amsterdam, di Delft.
“L’acqua non ha direzione in questa città, essa offre questa città. Ognuna è la sorgente dell’altra, e la città acquista se stessa davanti al respiro di quest’acqua grigia meravigliosa, che vive come essa vive, scura, e concreta, e leggera come un’idea. Concedimi questo pensiero, passeggiando per quelle vie, in compagnia di mia madre e di mio padre, soli, al mattino.”
La relazione tra l’acqua e la città è una relazione di mutuo fondamento: “ognuna è la sorgente dell’altra’”. Come vedremo, si può dire lo stesso delle altre due relazioni fondamentali del libro: quella tra figlio, madre e padre e quella tra uomo, arte e mondo.
La stessa sottodeterminazione delle coordinate temporali non è altro che il riflesso di una proprietà caratteristica della relazione tra l’io narrante e i suoi genitori. La relazione tra figlio, madre e padre è descritta come una relazione di assoluta specularità o, meglio, di rispecchiamento.
“I nostri tre sorrisi, tanto simili e tanto diversi, silenziosamente immersi nell’intima luce che abita queste sale, si sovrappongono, e a me pare come se una cattedrale qui fosse creata che si specchia in un’altra cattedrale. Di questo è fatta la luce che contiene i nostri sguardi e li unisce.”
La relazione è ancor meglio caratterizzata come una relazione di mutua generazione. I genitori generano il figlio e il figlio genera i genitori (oltre che, logicamente, in quanto genitori) restituendo loro il mondo filtrato attraverso la propria esistenza. Se la prospettiva è quella del rapporto filiale, il centro del tempo dell’individuo – e non l’inizio – sta nel momento della nascita piuttosto che nel presente. “La nascita è l’avvenimento centrale della vita, accade sempre al centro del tempo, scorre in noi dal nostro tempo.” Si spiega così la struttura temporale del libro, la narrazione decentrata, il principio di indeterminazione che sembra vigere sulle azioni e sulle percezioni dell’io narrante. La coppia dei nostri genitori, “ciò che ci crea, che è inizio del tempo per noi, sta di fronte a noi nello sguardo di quello che è stato creato, nel momento in cui è stato creato. È questa la misura del tempo.” Ciò che Ricciardi ci suggerisce qui è che la relazione della generazione naturale, biologica, se concepita con chiarezza, diventa fondamento ontologico della categoria del tempo, diventa struttura della percezione emendata, ordine della mente liberata dal delirio egocentrico.
La relazione a tre termini tra figlio, madre e padre diventa il modello di un’altra relazione fondamentale: quella tra l’uomo, l’arte e il mondo. Uomo, arte e mondo stanno tra loro nella stessa relazione di rispecchiamento dinamico e di mutua generazione in cui stanno figlio madre e padre. La loro unità è quella delle antiche divinità a tre facce.
“La veduta di Delft mostra la concezione naturale del mondo, originata dall’uomo per se stesso; ed è il mondo ad originarla per lui. È l’uomo che la dà a se stesso, ma è il mondo che gliela trasmette.”
Nel caso dell’arte è pure evidente la natura dinamica della relazione di mutuo rispecchiamento, tanto nel momento della creazione dell’opera quanto in quello della sua fruizione: “Vermeer fa funzionare il meccanismo che è l’uomo, che fa coincidere col meccanismo della mente che ora può concepirlo con estrema e pura precisione.” L’arte fa da specchio al mondo e all’uomo, e pure li costituisce simultaneamente, ne è la condizione. Ci viene qui proposto un senso affatto inedito dell’idea dell’arte come “specchio della natura”. Il quadro non è uno specchio statico di una porzione di natura, una bieca riproduzione isomorfa di un accidente. Il quadro è una macchina da rispecchiamento, uno specchio dinamico, capace di rispecchiare la natura che ha davanti quando la ha davanti. Il quadro rispecchia la natura soltanto quando un uomo è davanti al quadro e lo guarda. Il quadro è per ciò “specchio della natura”, di quella natura che include la mente dell’uomo, ossia della sola natura che noi possiamo concepire. Analogamente l’uomo esiste – come individuo autocosciente, come mente che si conosce nel corpo – soltanto di fronte al quadro.
Un’altra triade fondamentale si trova implicata nella complessa dialettica del rispecchiamento e della mutua generazione. È quella costituita dallo spazio, dalla mente e dal tempo.
“Il quadro non è appeso nello spazio, non occupa nessuno spazio, lo sospende, ed è la forma che lo domina. […] la mente di Vermeer è lo spazio nel quale viviamo, nel momento del tempo, nello sguardo del quadro, […] Lo spazio nasce da un quadro di Vermeer e si libera la mente, e questa annuncia il tempo.”
La mente annuncia il tempo come dimensione puramente umana della percezione e della ineluttabilità della morte. Pur essendo un inno alla vita, Amsterdam è tutto percorso dal pensiero della morte e della sua ineluttabilità. La presenza umana, condizione del mondo, è però sempre “una presenza minina, ai limiti dell’inavvertibilità”. Il rapporto con la madre e con il padre è vissuto nella piena coscienza della sua fragilità, della sua transitorietà. La precarietà della perfezione, l’imminenza della possibilità della fine costituiscono la struttura invisibile del libro, il punto di fuga inattingibile. Non potrebbe essere altrimenti, posto che il sentimento della morte è sempre implicito nell’amore filiale.
Ma proprio nel momento in cui la morte viene evocata, quando l’idea della morte viene partorita dalla luce della vita, essa viene spinta più in là, e l’autore trova un nuovo appiglio per un più estremo vitalismo.
“Siamo frenetici in questa stanza, soli, sappiamo che il tempo sta per scadere. Il nostro spirito impara che il tempo sempre scade, ma anche che una volta dentro di esso, là nasce la carica di chi si descrive con la bellezza del nuotatore, che ripete su di sé, sulla sua più totale interezza, la bellezza della vita, fino a che essa non sia più che istante del respiro.”
La morte viene in qualche modo respinta proprio quando viene toccata come idea-limite. Si sente qui chiara – nella linquidazione linguistica del problema metafisico – la lezione stoica di Wittgenstein: La morte non è un evento della vita. La morte non si vive. Scrive per esempio Ricciardi:
“Da ogni vivere è tolta la morte, anche dai morti che saranno. Ma non può essere, oggi, il morire, tolto da chi già è morto. Per noi vivi anche il morire è tolto […].” “[…] così, domani mattina, partiremo, svegliandoci senza mai più vivere, e la morte senza mai più morire, avendo la morte senza mai più averla.”
Se la morte non è evento della vita, resta il problema del tempo. All’evidenza della transitorietà e dell’impermanenza (al senso del tempo come “inappartenente appartenere”) Ricciardi reagisce riconoscendo una forma di permanenza della totalità. Soltanto il tutto permane. È un tutto liquido come il mare, virtuale, informazionale, duttile come la mente eppure immobile. È un tutto che non nega il divenire, ma ne è anzi intessuto, pur essendone la condizione. In esso tutte le relazioni sono già date eppure tutte da percorrere, anzi da generare. I corpi sono già esistiti da sempre dove esistono ora, nelle stanze del museo davanti ai quadri, perché la relazione tra il soggetto che guarda in questo istante il quadro di Vermeer e l’esistenza del quadro di Vermeer è una relazione necessaria ed essenziale.
“Là, da quattrocento anni, ognuno di quei tre quadri, ha creato il nostro corpo, che poi, certo, è nato, perché doveva nascere, e non poteva non nascere, è questo l’ordine delle cose, di ciò che è vivo e che vive. Questo lo dico a te, mamma, e a te papà, perché non posso fare altrimenti.”
Lo spettatore preesiste al quadro, perché il quadro esiste solo per essere guardato, ma anche il quadro preesiste allo spettatore, perché esiste solo per essere guardato. Ma queste relazioni necessarie saranno attive e reali solo “nell’istante della presenza, nel momento unico dell’incontro, della mente caduta nel mondo”. Solo allora, come un genitore per il figlio, il quadro è un indice di quella “sola bellezza” che è “speranza d’incontro con tutte le altre bellezze”. Analogo discorso vale per la relazione tra il mondo e l’uomo. Non v’è dunque un ‘prima’ in cui il mondo possa essere concepito senza uomo, e un `dopo’ in cui si possa concepire un uomo senza mondo, né viceversa.
Echeggia in queste pagine una forma implicita e latente – quasi evocata dai luoghi e dalle opere d’arte – di metafisica leibniziana (“Non c’è possibilità di sfuggire all’ordine meraviglioso in cui stanno le cose.”, “Non so immaginare una vita nella quale io, mamma e papà non costeggiamo con gli ombrelli questa strada”) fusa con un immaterialismo berkeleyano, il cui apice è “Capire cosa succede ora, che siamo eternamente per un attimo l’uno di fronte all’altro”. Quasi che le due anime del Seicento e del primo Settecento trovassero qui una loro riconciliazione, possibile solo in un’opera d’arte, come solo nel corpo e nella vita del figlio si trovano fusi e risolti il padre e la madre, come “idea” e “esperienza”.
Il mondo è il migliore dei mondi possibili, perché tutte le possibilità sono date da sempre e per sempre insieme alle cose (prima della vita e dopo la morte) ma le cose non esistono se non quando la possibilità delle loro relazioni è messa in atto dal contatto con l’esistenza di un individuo umano che ne diventa termine. È anche questo il senso delle parole di Hawkings poste da Ricciardi in esergo all’opera:
“The information remains firmly in our universe. If you jump into a black hole, your mass energy will be returned to our universe, but in a mangled form, which contains the information about what you were like, but in an unrecognizable state. [Stephen Hawking rivede la sua teoria sui buchi neri, 2004, conferenza di Dublino]”
“L’informazione rimane stabilmente nel nostro universo”, ma dopo l’impatto con il limite del tempo, con il “buco nero”, l’informazione che costituisce l’individuo sussiste in una “mangled form”, e la sua decodifica richiederebbe almeno la stessa energia necessaria a ricreare l’individuo per intero. La metafisica in cui Ricciardi, poeta, affonda il suo viso disperato dalla morte non è un museo delle cere. Nel “tutto” di Ricciardi, nell’ “assoluto steso ogni volta tra un mattino e una sera”, è uno spazio in cui l’azione e la vita sono ancora possibili. Anzi, necessarie.
“Questa è la storia di tutto e di tutti, non dobbiamo far altro che seguire le radici che da ogni cosa portano a ogni altra cosa, per fa evolvere questo rapporto, tra me e gli altri, tra ognuno e tutti, per raggiungere e far agire il futuro, e fondare qualcosa di nuovo […]”
Non perdere i nostri aggiornamenti
Elaboreremo i dati personali forniti in conformità con la nostra politica sulla privacy.
Articoli Recenti
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO o la consistenza dell'individualità di Francesca Sallusti Questa opera ha il suo principio
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE di Francesca Sallusti Apre la mostra una sala dedicata a pittori coevi a Van gogh, come Renoir
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI Testo poetico di Francesca Sallusti sull'opera di Gianmaria De Luca DA "MAAM - MUSEO DELL'ALTRO E DELL'ALTROVE" di Gianmaria De Luca
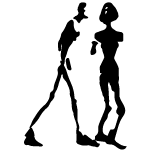


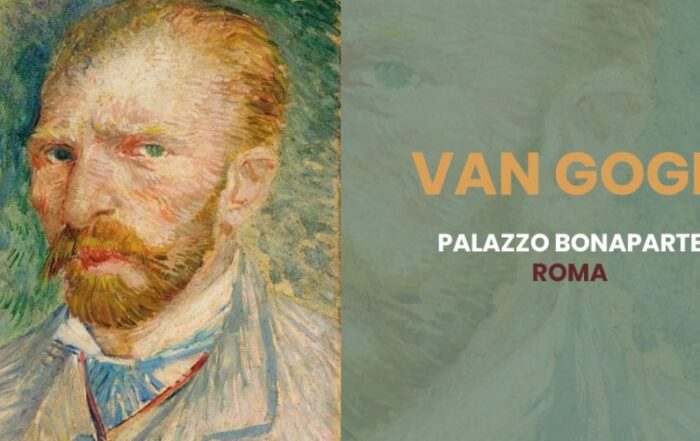

Scrivi un commento