La richiesta di Francesco Tomada in “A ogni cosa il suo nome” (Le voci della Luna, 2008) è una richiesta di completezza e correttezza del discorso. Per ogni cosa esiste un nome proprio (nel senso di adeguato) e attribuire ad ogni cosa il nome ad essa adeguato è un bene.
Una sorta di stoicismo cristiano riecheggia nel dettato di Tomada. Del Cristianesimo lo spirito aspro di verità, la spada di Cristo venuta a dividere, il discorso diretto al “sì sì e no no”, il coraggio dello scandalo, il coraggio della verità scomoda, anche violenta, anche negatrice della vita se necessario. Di questo spirito ritrovo l’eco nel libro di Tomada: “dicono che i figli diano forza ma non è vero / i figli dividono sono fatica / e non resta mai abbastanza tempo per sé e per noi”. Tomada ci richiama all’agnizione del dolore e del male; la visione del quale è temperata da una certa sconsolata atarassia (sentimentale e morale). Non c’è (non deve esserci) nessuna gioia (nessun compiacimento) nel dire il male come male e non c’è (non deve esserci) nessuna gioia (nessun compiacimento) nel dire il bene come bene. Quasi: nessuna pietas nel riconoscere la fragilità della vita. O meglio, e qui incontriamo la radice stoica di Tomada, soltanto una pietas razionale e filosofica è possibile. La pietas che deriva dalla verità (impersonale, atarassica), non dal sentimento.
A ciò si collega il tipo ricorrente nelle figure retoriche del libro. Tomada basa spesso i suoi componimenti su una metafora che mira all’esattezza, fondata su una proporzione razionale, o pure logica, fondata sui meccanismi della negazione, della contraddizione o della complementarità. Il terremoto è definito come “il contrario del vento”, perché la terra si muove e l’aria sta ferma, i bambini di Beirut che paradossalmente giocano alla pace, “la coda di un aereo abbattuto / non è come quella di una lucertola”; i due termini della metafora si toccano in una complementarità geometrica, come “il negativo e l’immagine”: “a ognuno quello che gli spetta: / a me un pezzo di carta e dentro / un buco a forma di cuore”, “[…] il tuo corpo ha / la forma del mio dolore”, .
Ma ancora più profondamente, Tomada ricerca la proprietà della metafora. I due termini della “metafora perfetta” di Tomada devono stare tra loro come il colore sta alla rosa. Abbiamo qui il riflesso più diretto della filosofia cristiano-stoica, e di un certo essenzialismo: esiste (anche se non è data) la natura delle cose e su questa natura si fonda la possibilità di una attribuzione propria (possibilità della verità del discorso) e la possibilità della responsabilità (possibilità del valore etico delle azioni).
In questa prospettiva sembra spiegarsi pure la posizione di estraneità del poeta rispetto alla creazione. Non è mai il poeta l’agente della creazione o della trasformazione. “guarda come è ostinata la bellezza / si ricostruisce da sola”, “quando ho messo in te il mio seme / il mio gesto voleva essere di amore / ma somigliava più a un atto primitivo / […] / mentre tu trasformavi in embrione / il mio sentirmi vivo”, o ancora “io penso a gino paoli / che in mezz’ora con una prostituta / scrisse una canzone che parlava d’amore”.
La poetica di Tomada non è una poetica – Romantica – della creazione. Non è neppure una poetica decadente o crepuscolare della impossibilità o inutilità della creazione. Non è mai il poeta a creare la vita, il bello. Il poeta aspetta (“io sto aspettando”), vive, abita (“io vivo qui”) , o, infine, appartiene. La poetica di Tomada è una poetica dell’appartenere.
“è inutile combattere bisogna appartenere
diventare umili e abitare con pazienza
come fa il colore su una rosa”
L’uomo deve appartenere al mondo come il colore appartiene alla rosa. Ecco il corollario ultimo della “filosofia della proprietà” di Tomada. Il colore rosa appartiene alla rosa quasi essenzialmente. In questo caso la ‘proprietà propria’ appartiene alla cosa al punto tale da diventare definitoria, da diventare nome della cosa.
Così l’uomo, appartenendo al mondo (e l’individuo appartenendo al proprio luogo), dovrebbe renderlo umano. Ecco perché il poeta Tomada appartiene ai luoghi più di quanto i luoghi non appartengano al poeta. Il poeta appartiene ai luoghi, inerisce ad essi, il poeta si predica nei luoghi della sua poesia, il poeta diventa una proprietà. E, se è bravo poeta – sembra suggerire Tomada – il poeta può diventare proprietà essenziale dei luoghi. L’uomo può diventare proprietà essenziale del mondo, “proprio” del mondo – e rendere perciò il mondo umano.
Una tale appartenenza non è data, non è immediata. Va – paradossalmente – conquistata combattendo. Combattendo “con pazienza”. La guerra qui è etica e noetica, contro le contingenze che offuscano lo sguardo a confondere proprietà essenziali e inessenziali, visibili e invisibili, beni apparenti e beni reali. La guerra qui è – stoicamente – contro le passioni, e – ancora cristianamente – contro se stessi (“così ti stringo per proteggerti – proteggerti da cosa mi chiedo / e rispondo: in notti come questa per proteggerti da me“). E’, ancora, una guerra paziente di adattamento. Ma la poesia è filosofia applicata, e non teoresi, e per tanto la guerra è anche contro la stanchezza, contro e nei propri limiti, contro le proprie ferite.
Non abbiamo certo qui un libro di pensieri filosofici, bensì la testimonianza (il martirio) di un esercizio: quello, per dirlo con le parole di un poeta a me caro, di “adattare le nostre braccia magre alla forza delle idee”. O della verità. Questa testimonianza è piena di dolore e di rabbia trattenute, che fanno digrignare i denti, scoppiare la testa.
Non perdere i nostri aggiornamenti
Elaboreremo i dati personali forniti in conformità con la nostra politica sulla privacy.
Articoli Recenti
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO o la consistenza dell'individualità di Francesca Sallusti Questa opera ha il suo principio
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE di Francesca Sallusti Apre la mostra una sala dedicata a pittori coevi a Van gogh, come Renoir
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI Testo poetico di Francesca Sallusti sull'opera di Gianmaria De Luca DA "MAAM - MUSEO DELL'ALTRO E DELL'ALTROVE" di Gianmaria De Luca
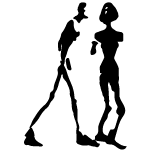


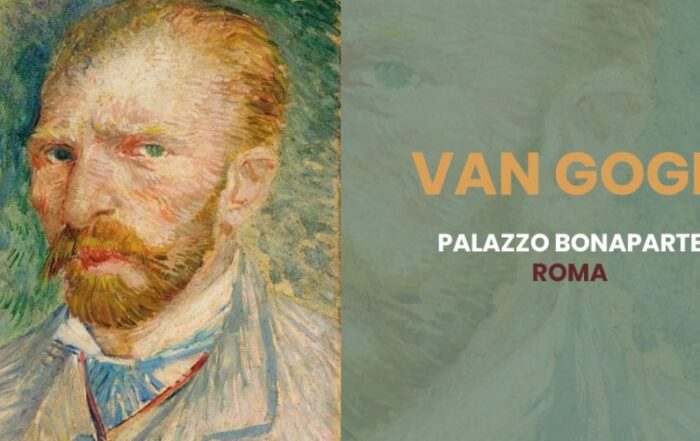

Scrivi un commento